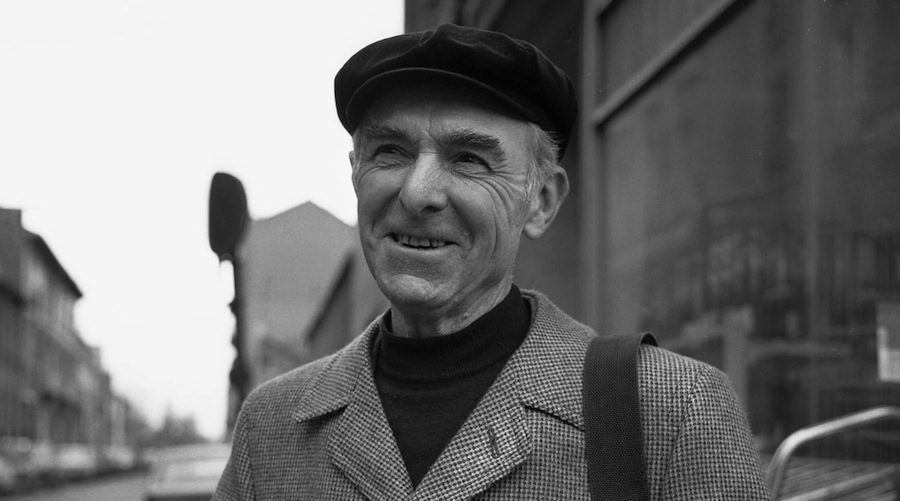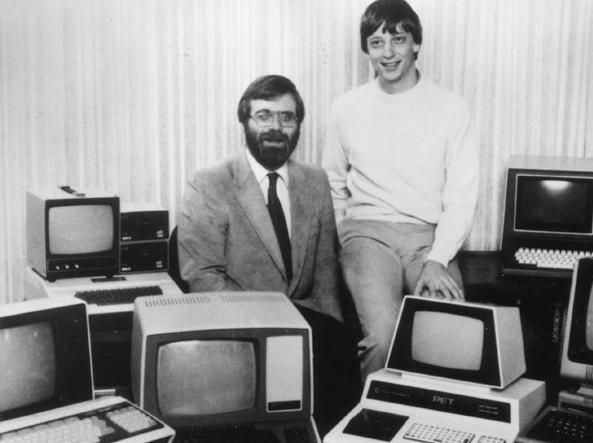World Press Photo 2025: uno sguardo potente sulla realtà
World Press Photo 2025: La toccante immagine di Abu Elou, il bambino amputato di Gaza.
Il premio 2025 World Press Photo è stato assegnato alla fotografa palestinese Abu Elou per lo scatto realizzato per il quotidiano New York Times, che ritrae Mahmoud Ajjour, bambino di nove anni gravemente ferito a Gaza. Si era voltato per incitare la famiglia a proseguire, quando un’esplosione gli ha portato via le braccia. Ora si trova in Qatar, dove sta imparando a giocare con il telefono, scrivere e aprire le porte usando i piedi, Mahmoud è stato gravemente ferito nel marzo 2024.