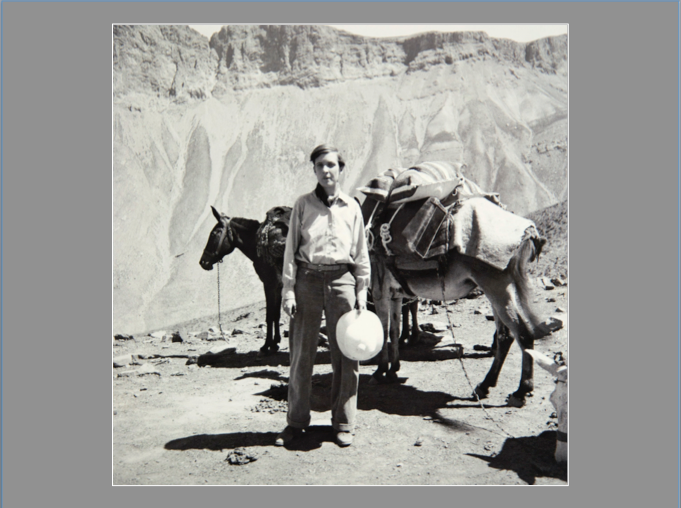TINA TURNER, ADDIO
L’abbiamo incontrata due anni addietro, nel giorno della sua nascita; oggi siamo costretti a dirle “Addio”. Il saluto è perentorio, perché anche i ricordi faranno fatica a esaltarne la memoria. L’hanno definita “La regina del rock 'n roll”, ma lei è stata la signora del rhythm and blues con il marito Ike, poi interprete del pop negli anni 80. Come dire, l’esistenza l’ha obbligata a vivere più volte: a cadere per rinascere, sin da bambina.
In macchina abbiamo appena ascoltato “Proud Mary": la storia di un battello a vapore che viaggia su e giù per il fiume. I versi di John Fogerty (autore del brano) furono cantati dai Creedence Clearwater in un “45 giri” del ’68. Nel 1971, Ike & Tina Turner ne produssero una cover che è diventata una delle canzoni più riconoscibili cantate da Tina.
La storia della canzone ci riporta a Mark Twain e alla vita lungo il Mississippi. Nel testo, riconosciamo un po’ la vita di Tina Turner: «La grande ruota continuava a girare. La Proud Mary continuava a bruciare, ondeggiando, ondeggiando; ondeggiando sul fiume». Da ieri quella ruota non gira più, ma se ne sente l’eco, che durerà a lungo.
Dopo quasi cinquant'anni nel mondo della musica, Tina Turner è diventata una delle rockstar internazionali di maggiore successo commerciale. La voce sensuale e potente, le gambe incredibili, la bellezza longeva nel tempo, il sex-appeal e la sua storia indimenticabile hanno contribuito tutti al suo status leggendario. Le apparizioni di Tina sul palco sono diventate iconiche, non a caso Herb Ritts ha fotografato la top model Cindy Crawford mentre imita le movenze della cantante; e la somiglianza è accattivante, a iniziare dalle gambe! Per il resto, Tina Turner è stata grande nella vita, quella che le ha proposto tante difficoltà: familiari e sentimentali. Ne è uscita bene: che dire? Simply the best, come nella canzone.