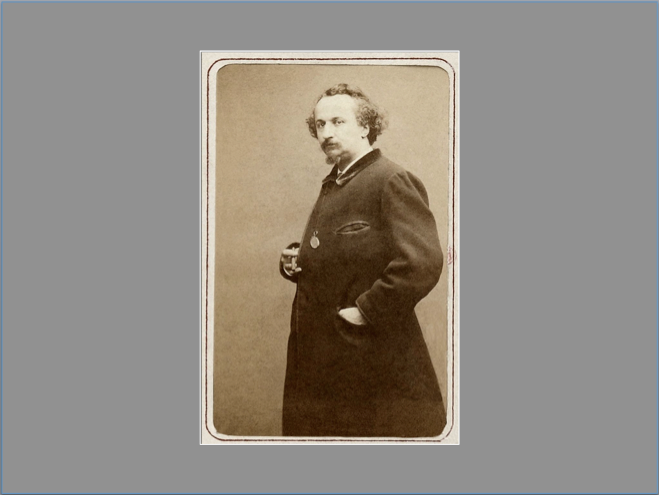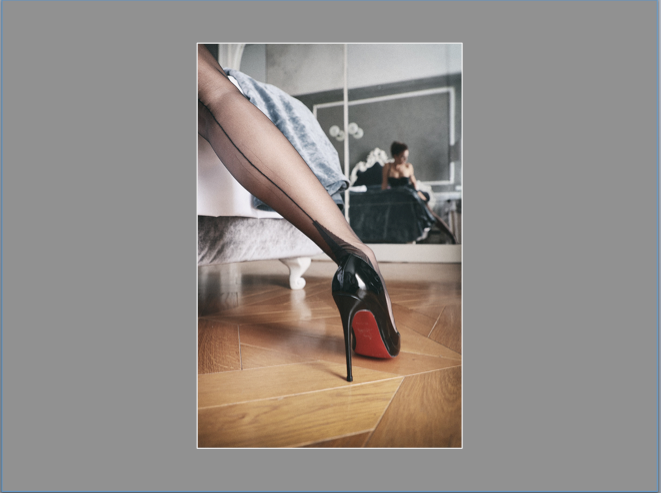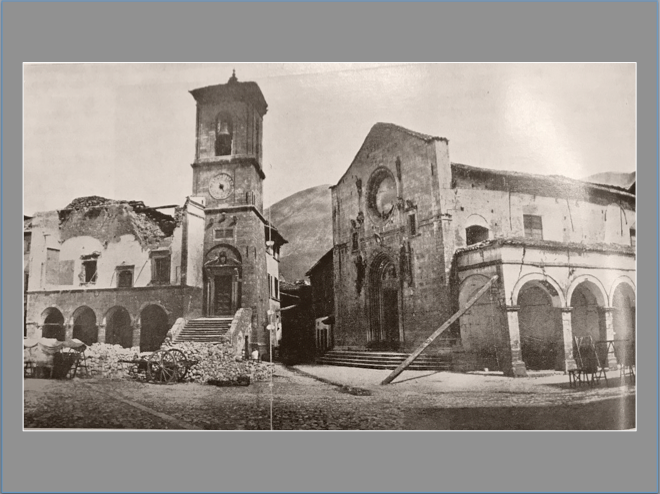PRIMA MACCHINA PER SCRIVERE
1 marzo 1873. La E. Remington and sons, inizia la produzione della prima macchina per scrivere commerciale negli Stati Uniti, con quello che diventerà il layout di tastiera più diffuso al mondo, il QWERTY.
Oggi, però, non possiamo dimenticare che il 1° marzo 2012 ci lasciava Lucio Dalla. Dodici anni senza di lui sono tanti, troppi. Siamo convinti che ci stia guardando di lassù, dalla stella che cantava. «Stella scendi giù, vienimi vicino; Entra dalla finestra, infilati nel mio taschino; Specchiati nel comodino della mia camera da letto; Io sarò lì dietro alla tenda, in silenzio che ti aspetto».
Altra notizia da ricordare. 1° Marzo 2002, le lire cessano la loro circolazione a doppia via con la nuova moneta europea, entrata in vigore il 1° gennaio. Ora la moneta ufficiale, a due mesi dal suo ingresso, è l'Euro, unica valuta scambiabile. E' la fine delle vecchie lire che cessano il loro corso legale per venire gradualmente ritirate dal mercato.
Torniamo alle macchine per scrivere e al layout della tastiera. QWERTY è lo schema più comune per le tastiere alfanumeriche. Il nome deriva dalla sequenza delle lettere dei primi sei tasti della riga superiore della tastiera (Q W E R T Y).
Nella tastiera QWERTY le coppie di lettere maggiormente utilizzate vennero separate, nel tentativo di evitare che i martelletti delle macchine per scrivere si incastrassero, costringendo chi scriveva a sbloccarli manualmente, spesso macchiando il documento.
Lo schema QWERTY tentava anche di dividere i tasti tra le due mani, in modo tale che mentre una mano si posizionava, l'altra colpisse il tasto, il che accelerò la scrittura; anche se poi ne venne studiata una variante, sempre per rendere più veloce la battitura, presentata nel 1932. Tuttavia il sistema QWERTY era ormai consolidato, con dattilografe e dattilografi ormai abituati alla relativa tastiera, così come le aziende produttrici di macchine per scrivere. Così il sistema non venne cambiato.
In Italia le tastiere per PC hanno assunto lo schema QWERTY, mentre quelle per macchine per scrivere si sono mantenute allo schema QZERTY, dove la Z è scambiata con la W e la M si trova a destra della L.